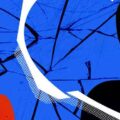Sempre più frequentemente vengono diffuse notizie di cronaca incentrate su episodi di violenza di genere, in cui la vittima subisce atti di aggressività da parte di una figura identificata come il carnefice.
Nella maggior parte dei casi, quando parliamo di episodi di violenza, la vittima è rappresentata da una donna e l’aggressore da un uomo, ma occorre fare una precisazione.
Spesso utilizziamo in maniera intercambiale espressioni quali violenza di genere, violenza contro le donne e violenza sessuale. In realtà, è importante chiarire le differenti accezioni che questi termini esprimono (Mosquera, 2023).
Cos’è la violenza di genere
L’espressione violenza di genere o violenza basata sul genere (dalla traduzione inglese Gender Based Violence, GBV) indica una forma di violenza che si caratterizza per essere indirizzata ad uno specifico target.
Questo è connotato dall’appartenenza a un genere considerato diverso, generalmente più debole e sfavorito.
A questa classe non appartengono solo le donne (anche se nella maggior parte dei casi sono proprio loro le principali vittime di violenza di genere), ma anche altre categorie di persone che, in generale, godono di una condizione svantaggiata.
La definizione di GBV parla di “ogni atto perpetrato contro la volontà di una persona e basato su norme di genere e su relazioni di potere asimmetriche”.
Queste violenze sono agite soprattutto contro donne e ragazze, ma anche contro uomini, persone LGBT, bambini, membri di minoranze etniche o religiose.
Le vittime
È stato evidenziato come maggiore è la rigidità dei ruoli di genere all’interno di una società, maggiore quindi l’asimmetria di potere tra generi, e maggiore è il rischio di violenza di genere.
Alla luce delle definizioni sopra delineate, risulta più chiaro perché l’espressione GBV non sia esattamente sovrapponibile a quella di violenza contro le donne. Questa rappresenta solo una delle forme con cui la GBV si si può manifestare.
Le forme di violenza
È importante specificare anche che la violenza contro le donne, su cui ci soffermeremo in questo articolo, non è riconducibile solo e soltanto alla violenza sessuale. Con questa si indica ogni atto, tentativo o minaccia di natura sessuale che degrada o danneggia il corpo e/o la sessualità della vittima, violandone la dignità, la libertà e l’integrità fisica.
Altre forme di violenza di genere includono:
- violenza fisica, ovvero aggressività non connotata necessariamente dalla componente sessuale;
- violenza domestica, perpetrata contro persone che vivono nella stessa casa o nello stesso nucleo familiare, può essere indirizzata non solo a donne ma anche a bambini, anziani, persone inferme. Quando l’aggressore è il partner, si parla di Intimate Partner Violence;
- violenza economica, ogni tentativo di controllo economico della vittima, attraverso la limitazione all’accesso alle risorse o la proibizione a raggiungere la propria indipendenza. Dd esempio il negare il permesso di trovare un’occupazione;
- violenza psicologica, comprende, senza necessariamente il coinvolgimento della forza fisica, ogni atto di potere manifestato attraverso umiliazione, svalutazione, negligenza, offese, derisioni, spinta all’isolamento della vittima.
Intimate Partner Violence: il ciclo della violenza di genere
Uno degli aspetti psicologicamente più complessi nella comprensione del fenomeno riguarda la dinamica e i fattori che spingono una donna a mantenersi all’interno del ciclo di violenza.
Già nel 1979, la ricercatrice Leonore Walker aveva osservato la presenza di un ciclo ricorrente all’interno delle situazioni di violenza domestica, identificato come il ciclo della violenza di genere.
Esso prevede la presenza di tre fasi riconoscibili.
Fase 1
La prima fase è quella di accumulo della tensione, che include comportamenti verbali quali accuse, colpevolizzazione, svalutazione, sarcasmo, derisione pubblica, continue offese e critiche, sguardi punitivi o di rimprovero che fanno sentire la donna inadeguata e sbagliata.
Il fine è quello di esercitare un controllo ossessivo e possessivo sulla vittima e iniziare ad indebolire la sua fiducia in se stessa.
Può durare per giorni, settimane, mesi o anni. La vittima tende a interpretare questi incidenti come situazioni isolate, credendo che non si ripeteranno, e cerca di calmare l’aggressore, negando ciò che sta accadendo o giustificando le vessazioni.
Fase 2
La seconda fase è quella dell’esplosione, con aggressione fisica, psicologica e/o sessuale.
Rappresenta il momento di massimo pericolo per la donna e per i figli, qualora presenti.
In questa fase le donne, dopo una prima reazione di incredulità, possono arrivare a chiedere aiuto e a denunciare i maltrattamenti.
Fase 3
La terza fase è denominata luna di miele o pentimento. L’uomo comprende gli effetti negativi della violenza perpetrata e teme di perdere la donna, considerata come una preda e di sua proprietà.
Viene chiesto perdono da parte dell’uomo, che assicura di cambiare e di non essere più aggressivo in futuro.
Inizia ad essere premuroso, attento ai bisogni della compagna ed amorevole.
Questa, al contrario della precedente, è la fase in cui le donne tendono ad abbandonare il percorso iniziato di uscita dalla violenza ritornando, così, dal maltrattante.
Il ciclo ricomincia!
Strategie di difesa, distorsioni cognitive e falsi miti
Spesso le donne vittime di Intimate Partner Violence adottano meccanismi di difesa protettivi, che rappresentano un tipo di risposta automatica a situazioni complicate che la persona si trova a gestire (Mosquera, 2023).
Tra le strategie difensive più comuni, che si configurano come ulteriori fattori di mantenimento del problema, troviamo:
- Negazione: la vittima nega la realtà, non vuole parlare di ciò che è accaduto, come se dicesse a se stessa: “Se non ne parlo e non ci penso, è come se non fosse successo”.
- Razionalizzazione: spesso associata alla giustificazione, è una manifestazione cognitiva e verbale sconnessa dall’aspetto emotivo. La vittima può trovare spiegazioni alle violenze subite, con affermazioni del tipo: “Mio marito lavora molto, ha bisogno di trovare pace e tranquillità quando torna a casa, se non ci comportiamo tutti bene è ovvio che si irriti”, oppure “È ovvio che abbia questa reazioni la sua vita non è stata facile”. Talvolta questo si accompagna ad una auto–colpevolizzazione della vittima stessa, che si attribuisce la responsabilità dell’accaduto, portando ad un meccanismo denominato vittimizzazione secondaria.
- Proiezione: questa difesa permette alla vittima di gestire l’angoscia e il disagio spostando il focus all’esterno, su terzi, come bambini o altri familiari: “Se mia madre avesse tenuto la bocca chiusa, le cose non sarebbero andate così”; “La bambina è sempre stata insopportabile, se non avesse pianto così tanto lui non si sarebbe infastidito”.
- Minimizzazione: è la tendenza a relativizzare ciò che è successo, spesso associata alla disconnessione emozionale, ad esempio “A volte diventa aggressivo, ma in realtà è una brava persona e non vuole fare alcun male; “Sono stati giusto un paio di colpi, non sono neanche dovuta andare in ospedale”
- Evitamento: spesso combinata con la difesa di negazione, si può manifestare cambiando argomento o ponendo l’accento su altre questioni, ad esempio: “In questo momento è importante pensare ai bambini, mi occuperò del padre in un altro momento; vorrei cercare di non finire in tribunale”. Quando sono presenti dei minori, spesso la donna vittima di violenza è portata a credere, sostenuta anche da una serie di falsi miti sociali e culturali, che un’eventuale separazione possa essere nociva per i figli, costretti a vivere un allontanamento dalla figura paterna, senza riuscire a considerare invece l’effetto dannoso provocato nei bambini proprio dall’esposizione a episodi di violenza assistita.
- Idealizzazione: indica la tendenza a ignorare le imperfezioni e i difetti e ad estremizzare gli aspetti positivi; può bloccare la capacità di avere una visione integrata del rapporto nel suo insieme e porta la vittima ad avere un’immagine distorta ed eccessivamente positiva del perpetratore (Royle e Kerr, 2010). A volte questa difesa si accompagna ad una distorsione cognitiva per la quale la vittima arriva ad attribuire agli abusi dell’aggressore intenti benevoli: “Il mio compagno si comporta così perché mi ama tanto”; “È geloso perché ci tiene”. Strettamente legato all’idealizzazione è il costrutto di affetto positivo disfunzionale (Mosquera e Knipe, 2017), che indica l’enfatizzazione di momenti sporadici postivi intercorsi durante la relazione, a fronte di altri numerosi e gravi episodi di violenza. Tali strategie difensive e distorsioni cognitive hanno lo scopo di “proteggere” la vittima da intensi vissuti di angoscia, terrore e impotenza legati alle violenze subite.
Vulnerabilità storica e trauma attuale
A rendere più complicato per la vittima sganciarsi dalla relazione abusante può contribuire un fattore molto significativo: la propria esperienza di vita.
Spesso, infatti, le vittime di violenza hanno vissuto durante la loro infanzia esperienze relazionali avverse, o propriamente traumatiche, con la propria figura di attaccamento, ovvero l’adulto deputato alla cura e al soddisfacimento dei bisogni emotivi e fisici del piccolo (Bowlby, 1988).
L’attaccamento alla figura di riferimento è una tendenza universale e innata, indispensabile allo sviluppo del senso di sicurezza e protezione. Quando la figura di attaccamento non è in grado di soddisfare efficacemente i bisogni del bambino, il sistema di attaccamento può assumere connotati disfunzionali (Ainsworth et al.,1978).
Attaccamento disorganizzato
In particolare, una delle declinazioni in assoluto più disfunzionali si verifica quando la figura di attaccamento agisce nei confronti del bambino un atteggiamento violento, minaccioso, abusante, determinando la formazione di un legame di attaccamento definito disorganizzato.
La figura di riferimento è contemporaneamente fonte di sopravvivenza e di minaccia, pericolo. Talvolta, l’abuso è l’unico modo in cui un bambino o una bambina sente di “essere visto” e questo può portare a percepire il perpetratore come “l’unica persona che mi vuole bene e si preoccupa per me”.
Quando il bambino è sottoposto a episodi di violenza da parte di persone significative può sviluppare una vera e propria sintomatologia traumatica. In particolare, quando il trauma è di natura interpersonale, perpetrato da persone significative, cronico, ripetuto e prolungato, la vittima può sviluppare quello che è stato definito come Disturbo da Stress Post Traumatico Complesso o PTSD-complex (Liotti, 2011).
Questo ha correlati sintomatologici importanti, tra cui anche esperienze dissociative e frammentazione della personalità.
Conseguenze dell’attaccamento disorganizzato
La modalità relazionale che il bambino adotta nei confronti della figura di attaccamento è caratterizzata da un’alternanza di rappresentazioni non integrate di sé e dell’altro. Tale meccanismo tende a ripetersi anche nelle relazioni interpersonali adulte.
Un bambino o una bambina vittima di violenza da parte delle figure di riferimento arriverà a sviluppare un modello interno che funzionerà da base per la costruzione di relazioni future. La figura emotivamente più vicina e significativa, come appunto un partner, rappresenta al tempo stesso anche la fonte della violenza e del pericolo.
Ecco allora che l’idealizzazione, con il cosiddetto attaccamento al perpetrator, è la modalità attraverso cui si mantiene vivo l’attaccamento ad una figura che è talvolta abusante, talvolta amorevole (Mosquera, 2023).
Nei casi più gravi, la donna che subisce violenza nell’età adulta sperimenta una ri-traumatizzazione già vissuta nell’infanzia e di nuovo il meccanismo protettivo dell’idealizzazione continua a ripetersi e continua a mantenere separate “la parte buona” da quella “cattiva”, non portando a percepire l’aggressore nella sua totalità.
Possibilità di intervento terapeutico
Vi sono alcuni fattori che rendono particolarmente difficoltoso per le vittime di violenza chiedere aiuto. In particolare, è importante tener conto della presenza di alcune emozioni difficili che “bloccano” la richiesta di aiuto.
Tra queste la paura che denunciare una situazione di violenza possa mettere in pericolo se stesse o i propri figli. La vergogna derivante dall’umiliazione e dal timore del giudizio esterno. Il senso di colpa dovuto al sentirsi corresponsabili sia della violenza subita sia della rottura della famiglia. Il dispiacere e l’ambivalenza nei confronti del partner, per la presenza dell’attaccamento al perpetrator di cui abbiamo parlato in precedenza. Infine, il sentimento di impotenza rispetto alla possibilità di trovare risorse efficaci per cambiare la situazione.
In generale, il piano di intervento per le vittime di violenza, che presentano una storia di traumatizzazione passata e un quadro di PTSD- Complex, dovrebbe seguire alcune fasi specifiche (Herman, 1997).
Le fasi del trattamento
In una prima fase di concettualizzazione si fa un inquadramento della vittima e si cerca di capire se si trova in situazione di sicurezza o di pericolo, attraverso l’esplorazione delle sue risorse e delle sue vulnerabilità. E’ importante offrire, attraverso la psicoeducazione, tutta una serie di informazioni per aiutarla a capire cosa le stia accadendo e a rendere più comprensibile la sintomatologia stessa.
La fase di stabilizzazione serve per insegnare alla vittima strategie per gestire gli effetti del trauma, promuovere abilità di regolazione emotiva, stabilire i confini, prendersi cura di sè, monitorare e validare i propri bisogni.
Successivamente si apre la fase dell’elaborazione delle memorie traumatiche, rivolta all’elaborazione dei ricordi traumatici e delle credenze negative ad essi associate.
L’EMDR e le altre strategie di rielaborazione traumatica
Esistono varie tipologie di protocolli di intervento, tra cui quello denominato Eye Movement and Desensitization and Reprocessing -EMDR (Shapiro, 1989). Questo prevede, attraverso una stimolazione bilaterale alternata, la rielaborazione dei ricordi traumatici partendo dalle immagini peggiori riferite dalla vittima. Dall’identificazione delle credenze negative sottostanti e dalla descrizione delle emozioni negative e delle sensazioni corporee associate.
Un aspetto importante da tenere in considerazione riguarda la presenza dell’idealizzazione e dell’affetto positivo disfunzionale, descritti in precedenza. Questi spesso inducono la vittima a sperimentare ambivalenza anche nell’ambito della terapia, in cui riportano immagini e ricordi contrastanti.
Ciò può rappresentare un forte ostacolo al processo di rielaborazione dei ricordi traumatici che lasciano il posto ai ricordi dei “momenti migliori” (Mosquera e Knipe, 2017).
In questi casi è possibile applicare una variante del protocollo EMDR, chiamata LOPA (Level Of Positive Affect Procedure, Knipe, 2005) che parte proprio dall’identificare una memoria positiva, associata all’affetto distorto idealizzato.
La stimolazione bilaterale alternata, in questo caso, è finalizzata a far emergere, a fianco dei ricordi positivi, anche le memorie relative ad aspetti negativi, in un’ottica di sempre maggiore integrazione.
Infine, nell’ultima fase, si lavora sull’integrazione e sulla riabilitazione, al fine di ripristinare un progetto di vita soddisfacente e un senso del sé coerente e unitario.
Bibliografia
- Ainsworth, M., Blehar, M. C., Waters, E. & Walls, S.. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Bowlby, J. (1988). Una base sicura. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Herman, J. L. (1997). Guarire dal trauma. Affrontare le conseguenze della violenza, dall’abuso domestico al terrorismo. Roma: Giovanni Fioriti Editore.
- Knipe, J. (2005). Targeting positive affect to clear the pain of unrequited love, codependence, avoidance, and procrastination. EMDR solutions: Pathways to healing, 189-212.
- Liotti, G., & Farina, B. (2011). Sviluppi traumatici. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Mosquera, D. (2023). Libera. Comprendere e trattare gli effetti della violenza sulle donne. Milano: Raffaello Cortina Editore.
- Mosquera D., & Knipe, J. (2017). Idealization and Maladaptive Positive Emotion: EMDR Therapy for Women Who Are Ambivalent About Leaving an Abusive Partner. Journal of EMDR Practice and Research, 11(1), 54-66.
- Shapiro, F. (1989). Efficacy of the eye movement desensitization procedure in the treatment of traumatic memories. Journal of Traumatic Stress, 2, 199–223.
- Royle, L., Kerr, C. (2010). Integrating EMDR into your practice. Springer: New York.
- Walker, L., (1979). The Battered Woman Syndrome. Springer: New York.